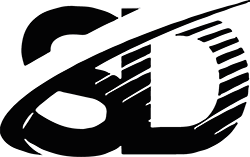Calciomercato: cos’è la clausola rescissoria?
Nel “calciomercato” italiano, soltanto negli anni più recenti si è sentito parlare della c.d. “clausola rescissoria” e, solitamente, ciò è accaduto quando una società di Serie A si è interessata ad un giocatore proveniente dalla Spagna.
Questa appena riportata è, in Italia, una locuzione impropria, che si è diffusa nel linguaggio giornalistico e degli operatori del settore dello sport professionistico e che viene utilizzata per designare uno specifico patto nei contratti conclusi tra la società sportiva e il tesserato.
Tale clausola consente al tesserato di sciogliersi anticipatamente dal contratto che lo lega ad una società sportiva mediante il pagamento di una somma di denaro predeterminata.
L’istituto in parola ha assunto, nel corso degli anni, delle finalità diverse rispetto a quanto sopra descritto.
Infatti, le squadre titolari del cartellino del calciatore fissano, nel contratto di lavoro subordinato che li lega e con l’accordo di quest’ultimo, una cifra spesso “esagerata” rispetto al vero valore del giocatore, utilizzandola come “barriera”, e questo perché le stesse vogliono proteggere i propri investimenti e i propri talenti dalle avances delle società avversarie e per “spaventare” queste ultime.
Andando, quindi, a fare una valutazione giuridica sui termini, si nota come non sia propriamente corretto esprimersi utilizzando la locuzione “clausola rescissoria”.
Infatti, stando a quanto stabilito nel Codice Civile, la rescissione è il rimedio applicabile ai contratti che risultano difettosi per determinati elementi anomali o riprovevoli, presenti in essi, quali: l’anomala condizione soggettiva che spinge una parte al contratto, uno stato di pericolo o di bisogno; lo squilibrio tra le prestazioni; lo sfruttamento dello stato di pericolo o di bisogno altrui.
Pertanto, è evidente che l’utilizzo dell’aggettivo “rescissoria” sia del tutto inappropriato per la clausola a cui si fa riferimento nei contratti calcistici.
La definizione di questa clausola, perciò, deve essere ricondotta ad altre tipologie di istituti che si trovano nel Codice stesso.
In realtà, il dibatto giurisprudenziale e dottrinale sulla natura e sull’inquadramento di tale clausola è ancora aperto e non certamente risolto. Sul punto, la dottrina che si divide e considera questa clausola in tre diversi modi:
- come una risoluzione anticipata per inadempimento con annessa clausola penale;
- come recesso unilaterale con annessa multa penitenziale;
- come risoluzione nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite con l’utilizzo di una clausola risolutiva espressa.
Sotto il profilo prettamente calcistico, questo tipo di clausola è nata in Spagna e la sua creazione portava con sé la volontà di armonizzare la libertà contrattuale dei calciatori e gli interessi delle società.
Il suo riferimento giuridico lo si trova all’art. 16 del Real Decreto n. 1006 del 26 giugno 1985, rubricato «Efectos de la extinción del contrato por voluntad del deportista». Qui, tra le altre cose, si stabilisce come il calciatore professionista possa estinguere il contratto, per cause non imputabili alla società, dietro il pagamento di un indennizzo.
Inoltre, si deve aggiungere che, per la dottrina spagnola, tale istituto è un presupposto obbligatorio; infatti, secondo essa, l’impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave pregiudizio alla libertà ed all’autonomia contrattuale del lavoratore.
Era idea comune, negli anni successivi alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri spagnolo ed alla emanazione del Re iberico del Real Decreto citato, che la clausola in questione valesse soltanto per il recesso del giocatore in favore di un’altra società spagnola.
In ambito F.I.F.A., il riferimento testuale alla “clausola rescissoria” si trova al titolo IV dello stesso Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, rubricato «Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società», adottato dalla Comitato Esecutivo della Federazione internazionale il 18 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 1° luglio 2005.
La risoluzione senza giusta causa, invece, la troviamo regolamentata all’art. 17 del Regolamento della F.I.F.A.
Ed è a tale articolo che si può ricondurre l’istituto qui analizzato. Mentre nel primo comma di tale articolo si fa riferimento al pagamento di un indennizzo da parte del soggetto che vuole recedere dal contratto e che tale risarcimento debba essere calcolato in base a determinati criteri oggettivi, nel secondo comma si fa presente come questo indennizzo possa essere inserito nel contratto o stabilito fra le parti.
Al secondo comma dell’art. 17, poi, è stabilito che spetta al calciatore corrispondere l’indennizzo, così come pattuito dalle parti, ma è previsto anche che lo stesso ne risponderà in solido con la nuova società.
Questo ci ricollega a quello che è l’ambito pratico di tale istituto nella realtà, ossia che è la società interessata ad acquisire le prestazioni sportive di quel determinato calciatore a provvedere al pagamento della clausola.
Dopo questa attenta analisi di quanto previsto dal Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori emanato dalla F.I.F.A., si riesce a comprendere meglio anche la diatriba sorta nella dottrina italiana e sopra riportata a proposito della natura e dell’inquadramento in ambito civile di questa clausola.
Infatti, la discussione si basa sul tipo di traduzione in italiano che viene fatta dal testo inglese della versione originaria del Regolamento internazionale:
- se si dà credito alla traduzione letterale di «the party in breach», allora si fa riferimento alla “parte che recede (che rompe il contratto)” e, di conseguenza, si sposa la teoria del “recesso con multa penitenziale”;
se, invece, si ritiene corretta la versione offerta dalla F.I.G.C. nella traduzione del regolamento internazionale, ossia di “parte inadempiente”, allora si vuole dar credito alla teoria della “risoluzione anticipata per inadempimento con annessa clausola penale”. giovanili.
Alla società cessionaria è data anche la possibilità di risolvere il contratto, con la compilazione di un apposito modulo, da depositare presso la Lega di appartenenza della società in cui il giocatore rientra. In tale modulo deve esserci il consenso di tutte e tre le parti coinvolte nell’istituto della cessione temporanea delle prestazioni sportive, quindi di entrambe le società e del calciatore.
Infine, pur rispettando quanto stabilito nel comma 2 dell’art 95 N.O.I.F. (ossia i limiti di tesseramento), viene data la possibilità alla società che ha ricevuto in “prestito” un giocatore di poter effettuare a sua volta una cessione temporanea dello stesso, anche nella medesima finestra di mercato, prevedendo però l’espresso consenso della società originaria.
Qualora si verifichi questa situazione, le clausole di obbligo di riscatto a determinate condizioni e il diritto di opzione sono risolte di diritto; mentre i premi di rendimento e di valorizzazione che risultano nell’originario contratto di cessione temporanea sono come non apposti, salvo diversa pattuizione da parte delle società interessate.
Passando all’ambito internazionale, la F.I.F.A. configura l’istituto del prestito all’articolo 10 del proprio Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori. Nel primo comma del quale viene richiesta la forma scritta ad substantiam, per poi andare a parificare il prestito alla cessione definitiva. Al secondo comma, inoltre, è previsto, come unico limite, che la durata minima sia quella intercorrente tra due periodi di tesseramento, differenziandosi così da quanto stabilito dalle normative italiane che prevedono anche un termine massimo di due anni.
31 agosto2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo